Marzio Barbagli, Uomini senza. Storia degli eunuchi e del declino della violenza. Bologna: il Mulino, 2023. 383 pp.
Marzio Barbagli è professore emerito di sociologia presso l’Università di Bologna, e il suo interesse per la sociologia storica è stato sempre evidente durante la sua carriera: diverse delle sue opere hanno infatti adottato una prospettiva decisamente diacronica. In questo filone si inserisce anche Uomini senza, libro dedicato alla storia sociale degli eunuchi dall’antichità fino a inizio Novecento.
A tenere insieme l’analisi di epoche così disparate è il desiderio di analizzare questo gruppo sociale seguendo l’intuizione di Max Weber, secondo il quale i castrati, lungi dall’essere stati una categoria del tutto marginale della storia mondiale, sono spesso stati in grado di organizzarsi come insieme coeso e solidale capace di contendere il predominio politico con i ceti sociali più elevati. Il filo conduttore del libro risulta così il tentativo di rispondere alla domanda dello stesso Weber, ovvero: perché in varie società storiche, nonostante il disprezzo nutrito per i castrati, essi sono riusciti a proporsi come un’élite amministrativa, intellettuale e talvolta anche spirituale? Accanto a questo interrogativo centrale, altre due domande fungono da fil rouge del testo. Innanzitutto, l’interrogativo sul genere che è stato attribuito agli eunuchi nelle varie civiltà in cui essi sono stati presenti in modo cospicuo: uomini come gli altri, anche se privi degli organi riproduttivi, esseri effeminati o ancora appartenenti a un terzo genere? In secondo luogo, la domanda suggerita già nel sottotitolo del libro: si può stabilire una correlazione significativa tra il ricorso alla castrazione umana all’interno di una data società e il livello di violenza che la caratterizzava?
L’opera procede in ordine cronologico, con il primo capitolo dedicato alle civiltà dell’antica Mesopotamia, dove gli eunuchi svolgevano perlopiù compiti di servizio al sovrano, che includevano l’educazione dei principi e talvolta anche il comando delle truppe. Nelle società assira, babilonese, ittita e persiana essi non erano considerati inferiori in quanto meno virili degli uomini ‘barbuti’, concezione che secondo Barbagli sarebbe stata ereditata anche dai Macedoni.
I capitoli successivi sono dedicati alla Roma classica e tardoantica, dove invece, specialmente in epoca più risalente, gli eunuchi erano visti con sospetto in quanto simbolo della dissolutezza delle società orientali opposta ai valori tradizionali della società romana. Ancora rari nei secoli della repubblica e del principato, gli eunuchi che giungevano a Roma erano in effetti perlopiù sacerdoti affiliati a culti di origine orientale oppure schiavi, anch’essi stranieri, castrati per preservarne i tratti giovanili al fine di prostituirli. Le cose cambiarono però in età tardoantica, quando l’ideale del princeps clausus, secondo cui l’imperatore doveva essere sempre più inaccessibile ai suoi sudditi per enfatizzarne la natura divina, rese gli eunuchi sempre più preziosi come servitori che potevano operare come schermo tra il sovrano e il resto della popolazione. Il loro valore si basava proprio sul fatto che la loro ascesa sociale era dovuta esclusivamente al rapporto di fiducia personale che essi avevano con l’imperatore, dal momento che gli eunuchi non avevano obblighi familiari a distrarli e non potevano – in virtù della loro mutilazione – sperare di rubargli il trono.
Tale ruolo degli eunuchi viene preservato nell’Impero Romano d’Oriente, dove però essi tendono a non provenire più, per la maggior parte, dal milieu degli schiavi. Sono invece gli stessi padri di famiglia bizantini (soprattutto in Paflagonia), a evirare i propri figli come strumento di ascesa sociale. A Bisanzio peraltro gli eunuchi assumono ancora più potere che a Roma, ricoprendo prestigiose cariche a loro riservate, come quella di guardiano delle stanze da letto imperiali (parakoimomenos), oppure svolgendo funzioni di generale o persino vescovo. Gli eunuchi a Bisanzio erano talvolta paragonati per le loro caratteristiche fisiche agli angeli, e quindi associati a un ‘terzo genere’.
Barbagli si concentra poi sul mondo islamico, dove pure a partire dalla dinastia omayyade e fino al XX secolo i castrati svolsero perlopiù funzioni di servizio ai sovrani. Di origine non araba e quindi all’inizio dell’espansione islamica reclutati soprattutto presso i popoli conquistati, essi divennero celebri nel mondo occidentale in particolare come guardiani dell’harem del sultano ottomano, ma in realtà svolgevano molte altre funzioni politico-amministrative.
L’ottavo capitolo è poi dedicato alla Cina imperiale. Le fluttuazioni nel numero di eunuchi impiegati presso la corte del sovrano, come anche nell’autorità a essi concessa, sono descritte con precisione da Barbagli, che colloca il loro apogeo nel periodo tra l’XI e il XVII secolo dopo Cristo, benché la loro popolarità si conservò fino alla caduta del Celeste Impero. Come a Bisanzio, e contrariamente a Roma e al mondo islamico, in Cina gli eunuchi non erano stranieri ridotti in condizioni di schiavitù, ma rampolli istruiti di famiglie locali, e in grado per questo motivo di competere con la burocrazia dei mandarini come élite amministrativa dell’Impero. Essi erano peraltro considerati come uomini a tutti gli effetti, in grado di sposarsi e adottare prole. Su questa possibilità incideva il peso del sistema di valori confuciano, secondo il quale era fondamentale che un uomo fosse in grado di assicurarsi una discendenza.
L’ultimo capitolo si concentra infine sugli ‘evirati cantori’ della tarda età moderna italiana, tra i quali il celebre Farinelli. Nonostante essi svolgessero perlopiù un ruolo di intrattenimento canoro, Barbagli sottolinea come anch’essi accedessero a volte a ruoli più spiccatamente politico-diplomatici, finendo per servire in questo modo i sovrani presso le cui corti si trovavano a cantare.
Questo libro si presenta quindi come un utile punto di partenza per il lettore, specialista o meno, che si approccia alla storia sociale degli eunuchi. Esso risponde in modo convincente alle prime due domande su cui si impernia, mostrando in modo dettagliato i meccanismi di ascesa sociale di questi uomini nelle varie società in cui la loro presenza è stata significativa e descrivendo la varietà di condizioni e atteggiamenti che li hanno caratterizzati (locali o stranieri, schiavi o appartenenti all’élite, idolatrati come star dell’opera o disprezzati in quanto dissoluti, considerati come una categoria di genere a se stante o come uomini a tutti gli effetti). L’interrogativo sul rapporto tra castrazione e violenza, tuttavia, non riceve un’analisi tanto approfondita quanto si vorrebbe. Sono presenti delle riflessioni conclusive sulla correlazione tra la ‘rivoluzione umanitaria’ cominciata nel XVIII secolo e il declino della pratica della castrazione umana; esse sono però piuttosto succinte e le loro basi nella documentazione presentata nel volume un po’ fragili (Barbagli stesso menziona come nel XX secolo molti stati abbiano reintrodotto una forma di castrazione, quella chimica, per punire gli autori di crimini sessuali). Nonostante ciò, Uomini senza risulta un libro basato su una solida e aggiornata bibliografia, e una ricca fonte di informazioni sulla storia sociale degli eunuchi.

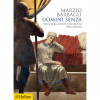

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License 2004- 2026
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License 2004- 2026
