Stefano Cavazza, Nazione, nazionalismo e folklore. Italia e Germania dall’Ottocento a oggi. Bologna, Il Mulino, 2024. 300 pp.
Quanto ha contribuito il folklore alla costruzione dell’idea di Nazione tedesca o italiana? Era o è ancora un mero elemento di appannaggio dei conservatori, un mondo a cui si guarda con nostalgia e di cui si avverte la perdita inarrestabile, da sempre alienato alle ideologie più moderniste? Oppure le tradizioni popolari sono state e sono tuttora un fattore determinante della costruzione della nazione, della propagazione di messaggi e della validità ed effettività di un’ideologia politica? Stefano Cavazza in questo interessante volume si propone di rispondere a queste domande e di illustrare tramite un’originale analisi comparativa l’impatto, spesso sottovalutato negli studi sul nazionalismo, delle tradizioni locali di Italia e Germania. Non casualmente, l’a. esamina due nazioni in cui le componenti regionali e provinciali hanno avuto un peso decisivo nella realizzazione della nozione di patria, e in cui i processi di immissione del folklore nel culto nazionalistico sono stati tutt’altro che lineari e unidirezionali. La compresenza di un mondo locale variegato caratterizza l’analisi rigorosa della storia contemporanea del nazionalismo dei due paesi, portando il lettore a riconoscere l’inscindibilità del folklore dal processo di creazione della Nazione, e del determinante contribuito offerto dai demologi per la concezione odierna di Italia o Germania. Il tema delle differenze locali permane nel corso dell’analisi, e porta il lettore a cercare di comprendere le motivazioni dietro gli sforzi dei demologi non solo di limitarsi alla conservazione del folklore ma anche alla difesa del suo intrinseco e “storico” valore di conditio sine qua non della coscienza nazionale.
Nella prima parte dell’analisi l’a. analizza i primordi dello studio demologico in Italia e Germania, ponendo in debita luce la commistione tra ricerca e salvaguardia delle tradizioni popolari e culto alla patria. L’analisi comparata dei due paesi segue di pari passo quella sull’evoluzione degli sforzi dei primi studiosi verso l’istituzionalizzazione dello studio del folklore: i demologi sembrano presentarsi come legittimi custodi e divulgatori del carattere e del sentimento nazionale. È interessante dunque osservare come l’analisi di Cavazza presenti le similitudini e differenze tra il movimento völkisch, ossia l’avvicinamento dei giovani tedeschi verso il “popolo” e il culto del passato glorioso, e le proposte in Italia del folklore locale come “ponte” verso la nazione. Notevoli sono le convergenze tra i due paesi, come il portato del trauma della Grande guerra nel nazionalismo e negli studi demologici. L’a. evidenzia inoltre lo sforzo di numerosi demologi di entrambi i paesi per trovare una consacrazione amministrativa e burocratica della propria disciplina.
Il volume illustra inoltre il primo effimero e fragile progetto, nel periodo tra le due guerre mondiali, per creare un coordinamento tra demologi e tradizioni popolari che travalicasse i confini regionali o nazionali. Cavazza delinea anche le traiettorie personali degli studiosi più celebri del fascismo e del Terzo Reich e la loro scelta di sottostare alle direttive del PNF (Partito Nazionale Fascista) e del KdF (Kraft durch Freude), ossia l’organizzazione dopolavoristica e ricreativa del regime nazista, speculare alla fascista Opera Nazionale Dopolavoro. Molteplici fattori determinarono le singole carriere dei demologi, a dimostrazione che una narrazione organica, che non abbracci i comportamenti e le ragioni individuali, non può fornire un quadro limpido del complicato rapporto tra dittature e intellettuali. Risulta dunque estremamente interessante osservare come i demologi, alle prese con una continua battaglia per ricevere legittimazione al pari di altre discipline scientifiche, si affidarono al fascismo e al nazismo convinti di entrare finalmente nel sistema accademico e burocratico. Cavazza, tuttavia, enuclea anche i punti di differenza tra Germania e Italia, evidenziando come mentre in Germania la sistematizzazione della demologia era in stato avanzato, con un fronte conservatore a cui Hitler attinse, in Italia essa difettava ancora di una linea coerente e le istanze erano variegate. Infine, il fattore della vicinanza delle ideologie fasciste con quelle di alcuni studiosi non viene messo in secondo piano dal saggio, che illustra le convergenze delle teorie demologiche di alcuni studiosi e il nuovo culto alla patria dei regimi di Mussolini e Hitler.
La seconda parte dell’analisi tratteggia il complicato passaggio del Secondo dopoguerra per la concezione del culto alla patria e per la demologia italiana e tedesca, in cui il termine nazionalismo venne sottoposto a una damnatio memoriae. La nazione tuttavia non scomparve, venendo infatti recuperata dalle diverse istituzioni del dopoguerra. L’analisi di Cavazza qui si divarica in una comparazione tra le divergenti interpretazioni, tra DDR e RFT, del ruolo delle tradizioni popolari nel costruire la nuova forma di politica nazionale. Le esperienze folkloriche permanevano dunque come forme di legittimazione politica, mentre il nazionalismo veniva sfumato e depurato delle componenti ormai “contaminate” dal nazismo, portando all’interesse verso nuove forme di cultura popolare. L’a. pone in evidenza come in entrambi i paesi la demologia ricercasse ciò che era andato perduto sotto la retorica nazionalista e imperialista nazista. Nel caso italiano Cavazza sottolinea la ritrosia della democrazia nell’epurare i demologi collusi col regime, mentre i vari partiti politici utilizzavano il mondo del folklore e del tempo libero per immettervi messaggi politici, preludio al passaggio della demologia verso uno studio dell’elasticità della cultura popolare, aperta alle contaminazioni moderne degli anni Sessanta e Settanta. L’a. rileva come, di nuovo, la Germania ebbe una fase più rapida di ripensamento della propria concezione di cultura popolare mentre in Italia l’eredità dei grandi demologi rimase intatta fino agli anni Ottanta. Le feste popolari nella DDR e il folk revival nella musica italiana sono i maggiori esempi riportati dall’a. di nuove tendenze della cultura popolare che subirono un’impennata nella seconda metà del Novecento.
Nella parte finale del volume Cavazza riprende le fila del ragionamento sul regionalismo e sul federalismo, fenomeno tornato in auge con i nascenti populismi e parte di una forma di nazionalismo xenofobo e antiglobalizzazione. In questo senso, l’a. chiude la sua analisi con la descrizione di come il folklore e la storia nazionale vengano decontestualizzati e reinterpretati, dipingendoli come antiche forme di protezione da influssi esogeni, e dunque minacciosi per l’essenza nazionale.
Il libro di Cavazza, in conclusione, si potrebbe porre come fonte di ispirazione per nuove analisi comparate atte a dimostrare l’importanza, odierna e passata, dell’utilizzo delle tradizioni popolari nella costruzione, invenzione o riformulazione del culto alla nazione. Si auspica che tale trattazione possa aprire nuove opportunità per comprendere la capacità del folklore e del nazionalismo di influenzarsi reciprocamente e di reinventarsi, adattandosi agli stimoli interni ed esterni e fornendo ancora oggi materiale fecondo per determinate visioni politiche.

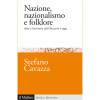

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License 2004- 2026
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License 2004- 2026
