Olindo De Napoli, Selvaggi criminali. Storia della deportazione penale nell’Italia liberale (1861-1900). Bari-Roma: Laterza, 2024, 368 pp.
In questo libro, molto accurato e ben scritto, Olindo De Napoli analizza il lungo e ricco dibattito sulla deportazione penale che ha animato il Regno d’Italia dalle sue origini all’inizio del secolo. Un dibattito che ha visto scontrarsi posizioni contrastanti e antitetiche, tra chi vedeva nella deportazione penale la panacea di tutti i mali, e chi, invece, la criticava in quanto forma di violenza insensata e pratica immorale, sia nei confronti dei detenuti sia rispetto alle popolazioni che abitavano i territori di destinazione. Non mancano, inoltre, le posizioni di coloro che nel corso del tempo hanno cambiato idea, dimostrando così la complessità e l’intensità di un confronto che in effetti ha coinvolto numerose personalità del mondo politico, giuridico, intellettuale e letterario, così come figure di esploratori e avventurieri.
Oltre alla molteplicità di soggetti coinvolti, l’autore approfondisce i diversi discorsi sulla deportazione penale che nel corso dell’Ottocento hanno riguardato non solo l’ambito legislativo, ma anche quello antropologico e coloniale. Le origini del tema della deportazione penale, infatti, vengono rintracciate nel contesto della lotta al brigantaggio e, in particolare, nella necessità di trovare al più presto una soluzione a tale fenomeno percepito come emergenziale e che sfocerà nella legge Pica del 1863. Ma questi sono anche gli anni in cui l’antropologo e medico veronese Cesare Lombroso aveva iniziato a elaborare la sua teoria sull’atavismo criminale che prenderà poi forma ne L’uomo delinquente (1876). Il discorso coloniale, invece, affondava le sue radici nell’imperialismo ottocentesco e quindi nella necessità di conquistare nuovi territori sia per dimostrare la grandezza e il prestigio nazionale, sia nella convinzione che i paesi europei avessero il dovere di civilizzare i popoli lontani considerati selvaggi. Al tempo stesso, molti politici e intellettuali vedevano nella colonia penitenziaria un efficace strumento di espansione coloniale, un primo passo verso la creazione di una colonia tout court. Il criminale, infatti, in colonia, avrebbe avuto la possibilità di riabilitarsi non solo per tornare a essere un cittadino a tutti gli effetti ma anche per diventare poi un vero e proprio agente della colonizzazione. Secondo alcuni, inoltre, la colonia penitenziaria rappresentava la soluzione ideale a molte altre questioni che minacciavano il neonato stato italiano. In primo luogo, avrebbe permesso di risolvere almeno in parte la questione dell’inadeguatezza delle case di pena, che erano sovraffollate e versavano in uno stato di abbandono e arretratezza. In secondo luogo, lo stato avrebbe potuto sfruttare il lavoro coatto dei reclusi. E in ultimo, ma non meno importante, la deportazione penale avrebbe facilitato la tutela della sicurezza sociale attraverso l’allontanamento e di fatto l’espulsione dal corpo sociale di soggetti considerati pericolosi e quindi indesiderati.
Questo aspetto, peraltro, rientrava all’interno di una più ampia strategia nazionale che aveva come obiettivo il controllo della pubblica sicurezza nascondendo o allontanando gli elementi di turbamento che rischiavano di compromettere la stabilità sociale. In questo senso, il soggetto criminale poteva essere assimilato, ad esempio, a quello psichiatrico a causa della pericolosità sociale attribuita a entrambi. Lo stato italiano, infatti, aveva già iniziato a dispiegare specifici dispositivi di controllo nei confronti delle cosiddette “classi pericolose” ed è proprio negli ultimi decenni dell’Ottocento che si assiste a un progressivo aumento del numero di manicomi e a un ulteriore ampliamento di quelli già esistenti. Un altro aspetto che accomuna il discorso penalistico e quello psichiatrico è l’idea del lavoro come strumento di riabilitazione. Come la “cura” per i pazienti psichiatrici passava attraverso la cosiddetta ergoterapia, la terapia del lavoro (i pazienti infatti erano impiegati nei campi o nelle varie attività presenti nei manicomi), similmente l’emancipazione del criminale dal crimine avveniva attraverso il lavoro in colonia. Oltre a ciò, i sostenitori della deportazione penale erano dell’idea che essa avrebbe portato a una rigenerazione del criminale grazie all’esperienza di una vita nuova, che poteva ripartire da zero. Il criminale, infatti, sarebbe stato deportato verso luoghi lontani nello spazio e, in un certo senso, anche nel tempo. Questo sradicamento del soggetto era necessario per far sì che egli tagliasse i legami con la comunità di appartenenza e dunque recidesse finalmente quelle reti criminali di cui faceva parte. L’allontanamento appunto era considerato il modo migliore per permettergli di “rigenerarsi”, “curarsi” e iniziare un percorso verso una nuova socializzazione. A questo discorso faceva eccezione la possibilità di un eventuale ricongiungimento con la famiglia in colonia che, soprattutto i sostenitori della colonia penale come avamposto per la creazione di una futura colonia tout court, vedevano positivamente perché presupposto per la creazione di una nuova comunità coloniale.
Anche nell’insieme di coloro che erano favorevoli alla deportazione penale vi era grande varietà di opinioni. In particolare, ho trovato di grande interesse la posizione di alcune figure che utilizzavano come argomentazione a favore della deportazione il fatto che le prigioni – per com’erano all’epoca – “non correggessero ma corrompessero ulteriormente il criminale”: queste le parole, ad esempio, del deputato Stefano Castagnola (ex mazziniano poi spostatosi verso i moderati). O ancora, l’opinione di Biagio Caranti, incaricato dal ministro Torelli di capire se si potesse iniziare la colonizzazione penitenziaria, che in una sua relazione aveva sostenuto come la prigione non fosse in grado di rendere innocuo il delinquente e anziché migliorarlo e riabilitarlo, lo avrebbe “intristito” sempre più.
Questo aspetto è interessante perché il tema della progressiva istituzionalizzazione dei soggetti reclusi in quelle che il sociologo Irving Goffman ha definito “istituzioni totali” torna poi, naturalmente in altre forme e con obiettivi diversi, all’interno delle lotte antistituzionali degli anni Sessanta e Settanta (ad esempio nei vari movimenti di lotta per la chiusura degli ospedali psichiatrici, ma anche nei movimenti studenteschi).
La ricchezza delle fonti utilizzate è notevole. L’autore ha analizzato numerose fonti archivistiche, fonti primarie edite, periodici, raccolte ed edizioni di atti parlamentari del Regno d’Italia, qualche fonte letteraria e qualche memoria. In particolare, negli ultimi due capitoli del volume, viene affrontato il caso della deportazione di 196 condannati al domicilio coatto ad Assab nel 1898. Tra questi, emblematico è il caso dell’anarchico Borsoni di cui sono ricostruite le vicende attraverso l’analisi di una sua memoria. Molto apprezzabile e ammirevole, in questo senso, la volontà dell’autore di entrare, per quanto possibile, nelle storie personali di alcuni soggetti coinvolti in questa storia: sia della tragica sorte dei 196 deportati ad Assab, ma anche di alcuni esploratori e avventurieri che hanno contribuito con i loro viaggi di scoperta al processo di ricerca di luoghi adatti alla realizzazione di questa impresa.
In conclusione, il volume di De Napoli offre una panoramica dettagliata e accurata di un dibattito che è stato importante nella definizione del giovane Regno d’Italia e che – a mio parere – parla molto anche all’oggi.

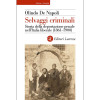

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License 2004- 2026
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License 2004- 2026
