Rory Naismith, Making Money in the Early Middle Ages, Princeton - Oxford, Princeton University Press, 2023, IX-516 pp.
Professore di storia dell’Inghilterra nell’alto Medioevo al Corpus Christi College di Cambridge, Rory Naismith è uno specialista della moneta e dei suoi utilizzi. «Utilizzi», al plurale, perché il libro di cui ci occupiamo qui esamina le caratteristiche, i cambiamenti e le diverse funzioni dello strumento monetario, principalmente (ma non esclusivamente) in Europa occidentale, tra i secoli V e XI. Making Money in the Early Middle Ages è un’opera ispirata da obiettivi ambiziosi, che, tuttavia, hanno condotto in più punti l’A. verso conclusioni dichiaratamente provvisorie o ipotetiche – e presentate come tali con grande chiarezza e onestà. Non si tratta, insomma, di un testo costruito attorno a una tesi forte o volto a dimostrare una big idea, secondo un orientamento di ricerca spesso adottato dalla storiografia anglosassone. Del resto, è proprio il già accennato «approccio funzionale» (p. 10, traduzioni mie) al problema della moneta che comporta la necessità di combinare diverse prospettive di analisi e, dunque, di vagliare tutte le possibili spiegazioni per i complessi fenomeni di cui fonti scritte e reperti archeologici danno conto.
Il libro può considerarsi un’estensione, dal punto di vista cronologico e geografico, del volume dedicato dall’A. a Money and Power in Anglo-Saxon England: The Southern English Kingdoms, 757-865 (Cambridge, CUP, 2012), in cui Naismith si proponeva di impiegare il «materiale numismatico e monetario per trarne conclusioni di più ampia portata storica» (p. 1). Making Money in the Early Middle Ages muove dalle stesse premesse e mira al medesimo scopo: si compone di un’introduzione generale (capitolo 1), seguita da una disamina delle “grandi domande” che fanno da sfondo al dibattito su monetazione e monete nell’alto Medioevo (parte 1, capitoli 2-5); monetazione e monete sono appunto l’oggetto della parte 2 (capitoli 6-9), che porta a una sintesi conclusiva (capitolo 10).
Naismith individua tre grandi cambiamenti avvenuti durante il periodo che prende in esame: la scomparsa del sistema monetario tardo-romano nel corso del V secolo e, congiuntamente, dell’oro come metallo più prezioso impiegato nelle coniazioni e dei numerosi, piccoli tagli in leghe di rame utilizzati negli scambi quotidiani (p. 193); il passaggio all’argento, iniziato verso la seconda metà del VII secolo in alcune zone affacciate sul canale della Manica e sul mare del Nord (p. 274); e, infine, un ricorso alla moneta sempre più diffuso – e testimoniato da un ampio numero di ritrovamenti in diverse regioni europee – tra l’ultimo trentennio del X secolo e l’inizio dell’XI (pp. 322-326). Si tratta di fenomeni tanto importanti quanto ancora relativamente oscuri, di cui non è sempre facile descrivere lo svolgimento preciso e individuare le cause profonde. Per cercare di districare la matassa, l’A. identifica tre ragioni principali che spiegano la produzione di moneta e che corrispondono ad altrettante funzioni svolte dalla moneta stessa: la spesa dello stato per la retribuzione di esercito e burocrati («state expenditure model»); la domanda dello stato, che consiste principalmente nella richiesta di tasse («state demand model»); e la domanda locale, alimentata sia da detentori di uffici pubblici, sia da privati («local demand model») (pp. 53-55). In termini molto generali, l’Europa latina tra V e XI secolo assistette a un passaggio dal primo al terzo modello, sebbene Naismith sottolinei come non si sia trattato di una transizione lineare, uniforme e comune a tutte le aree di cui si occupa il libro.
All’interno di questo quadro interpretativo di riferimento trovano spazio molte questioni ancora aperte, domande senza una risposta certa e conclusioni da verificare. Sostenere, per esempio, che la scomparsa dell’oro in Occidente dopo il 500 circa sia dovuta all’affievolirsi delle relazioni commerciali con l’impero romano d’Oriente è un modo, come nota l’A., di «fare a scaricabarile» (p. 40), perché non sappiamo con esattezza da dove provenisse l’oro coniato a Bisanzio. Ancora, l’apparizione dei primi pennies d’argento in Inghilterra «lascia particolarmente interdetti» (p. 279). I pennies erano il risultato della fusione di pezzi più antichi, da cui si ricavava il metallo prezioso altrimenti quasi completamente assente nelle isole britanniche, ma ignoriamo chi ne abbia promosso la creazione: Naismith afferma, in modo inevitabilmente vago, che «una serie di pressioni giurisdizionali, signorili, sociali, politiche e militari sono le spiegazioni più probabili per le coniazioni» (p. 284). Si consideri, infine, il problema della quantità di monete in circolazione nell’alto Medioevo, che negli anni Sessanta del secolo scorso fu oggetto di «frecciatine sempre più taglienti» (p. 52) tra accademici: da che cosa dipendeva? E ci sono, oltre ai ritrovamenti archeologici, altri modi per conoscerla o stimarla? La divergenza di opinioni, sottolineata dall’A., tra alcuni dei più autorevoli studiosi della monetazione medievale sulla risposta da dare a queste domande è significativa. Peter Spufford (1934-2017) riteneva che la quantità delle coniazioni dipendesse, in generale, dalla scoperta di nuove miniere e quindi dalla disponibilità di metallo: era l’offerta, non la domanda, il fattore che determinava i livelli di produzione (p. 28). Philip Grierson (1910-2006), al contrario, pensava che fosse proprio la domanda a incentivare le attività di estrazione da giacimenti minerari spesso conosciuti da secoli, ma sfruttati con intensità solo da un dato momento in avanti, quando lo stato o i privati lo richiedevano (pp. 52-53). Grierson, inoltre, criticava le stime sul numero di pezzi in circolazione nell’alto Medioevo proposte dal grande numismatico Michael Metcalf (1933-2018), stime fondate sui ritrovamenti delle matrici da battitura, che Metcalf considerava indicatori affidabili del volume complessivo delle emissioni.
Lungi dall’essere una debolezza, la capacità dell’A. di dichiarare quel che non (si) sa rappresenta uno dei punti di forza del testo e mostra la vitalità di un campo d’indagine meritevole di ulteriori approfondimenti. Nella fattispecie, i capitoli finali di Making Money in the Early Middle Ages affrontano la vexata quaestio della “rivoluzione commerciale” del Medioevo, concentrando l’attenzione sul problema della «monetizzazione dell’economia» (p. 322), vale a dire del crescente ricorso alla moneta intorno all’anno Mille. Una prospettiva tanto più interessante se si considera che il libro è stato pubblicato pochi mesi dopo l’uscita di The Donkey and the Boat: Reinterpreting the Mediterranean Economy, 950-1180 (Oxford, OUP, 2023) a firma di Chris Wickham. The Donkey and the Boat assesta un duro colpo al paradigma interpretativo tradizionale della “rivoluzione commerciale”, ma non esamina, se non in modo marginale, la storia della moneta; e se è vero che la cronologia scelta da Naismith (400-1100) si sovrappone solo in parte a quella di Wickham (950-1180), il lavoro del primo ci aiuta ad arricchire le argomentazioni del secondo di nuove domande. Ne propongo tre, a mo’ di conclusione. Appare di grande interesse il problema della trasformazione del metallo prezioso da bene di lusso – trasportato in piccole quantità, ma su lunghe distanze – a bene di largo consumo – oggetto di scambi frequenti e consistenti che però avvenivano, principalmente, al livello di una singola zona o regione (pp. 60-61): quando si verificò tale trasformazione? Ancora, sappiamo che nel tardo Medioevo lo svilimento della moneta (vale a dire, la diminuzione del suo peso e della quantità di metallo prezioso contenuto all’interno) mirava a generare un profitto per gli stati, che mantenevano invariato il valore nominale del debito pubblico e dei salari, ma abbassavano il costo di produzione della moneta stessa, aumentando così le entrate per le casse pubbliche. Questa pratica non esisteva, pare, nell’alto Medioevo (pp. 60-67): quando ebbe inizio? Infine, l’inizio della «monetizzazione» dell’economia intorno al 970 coincide, con sorprendente precisione, sia con l’incremento del prezzo della terra in alcune regioni italiane ed europee, sia con i primi segni di svilimento del denarius argenteo coniato sotto gli Ottoni: qual è la relazione tra aumento della domanda e politiche monetarie come (con)cause dell’inflazione? Liberare la storia monetaria dai limiti in cui la numismatica l’ha talvolta confinata significa scrivere una nuova agenda di ricerca per l’economia medievale: il libro di Naismith rappresenta un importante contributo in questa direzione.

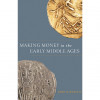

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License 2004- 2025
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License 2004- 2025
