Alberto Mario Banti, “Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd”, Roma-Bari, Laterza, 2017, IX-608 pp.
Può sorprendere che uno storico tra i massimi esperti di Risorgimento italiano, borghesie ottocentesche e culture del nazionalismo, a distanza di appena un anno dal precedente lavoro sui rapporti di genere nelle élites sociali del XIX secolo (Eros e virtù. Aristocratiche e borghesi da Watteau a Manet, Roma-Bari, Laterza, 2016), pubblichi un volume di oltre seicento pagine dedicato alla cultura di massa americana dagli anni Trenta del Novecento in poi, con un titolo che fa esplicito riferimento a Walt Disney e ai Pink Floyd. Può sorprendere ma non deve ingannare, il salto è meno ampio di quanto possa apparire in prima battuta: se con ogni evidenza l’oggetto di studio è distante - in senso spaziale e cronologico - dai temi affrontati in precedenza dall’autore, l’approccio metodologico è in linea con la sua propensione a una storia culturale attenta ai risvolti politici e sociali, prendendo in esame meccanismi produttivi, contenuti, morfologia delle narrazioni, ma anche circolazione, ricezione, pratiche di consumo.
D’altra parte l’a., come ha pubblicamente raccontato, da tempo teneva nel cassetto questo progetto, o più precisamente l’idea di realizzare un’indagine storica sulla musica rock, ispirata alla Storia sociale del jazz di Francis Newton, alias Eric J. Hobsbawm. Soltanto che, mettendosi all’opera, si è presto reso conto che la storia del rock faceva parte, in modo inestricabile, di un più ampio paesaggio culturale, la cui evoluzione ha rappresentato un fattore costitutivo dell’immaginario collettivo contemporaneo. L’esigenza è stata quindi quella di allargare lo sguardo all’intera parabola della cultura di massa americana nel Novecento. E il motivo di fondo risiede in un aspetto cardinale del sistema nel quale si è inserito anche il rock, ovvero l’altissimo grado di intermedialità, la forte interazione tra i vari mass media e tra i diversi settori dell’intrattenimento, l’incessante passaggio di contenuti, suggestioni, protagonisti, sponsor, consumatori da un ramo all’altro della produzione culturale rivolta alle masse (cinema, musica, editoria, radiofonia, televisione).
È nato così questo libro su «Wonderland», cioè sul canone narrativo veicolato su scala globale dal sistema mediale americano. Attraverso le parole dei romanzi, le trasmissioni radio, le figure dei fumetti, i suoni delle hit musicali, le immagini del cinema o della televisione, i media non solo hanno offerto divertimento a un pubblico enorme, ma hanno fornito anche uno strumento di soft power straordinariamente efficace. Si tratta dunque di un libro molto “americano” sia per le fonti utilizzate (una ricca gamma di trame cinematografiche, testi di canzoni, rappresentazioni letterarie ecc.), sia per il dialogo con una letteratura secondaria in buona parte anglosassone (oltre che multidisciplinare, con attenzione ai contributi provenienti da sociologia, antropologia, media studies ecc.), anche se il principale riferimento teorico è un classico del pensiero critico europeo: la Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno. Banti fa infatti largo uso di categorie tratte dall’opera dei due filosofi francofortesi (dal concetto di industria culturale al tema dell’omologazione), sebbene con alcune significative prese di distanza. In particolare, non condivide la severità dei loro giudizi morali ed estetici sulla cultura di massa (anzi, tutt’altro), né la considera come «un blocco monolitico».
La chiave di lettura adottata dall’autore consiste infatti nella diversificazione della cultura di massa tra «mainstream» (Banti mutua il termine dall’omonimo libro di Frédéric Martel) e «controcultura». Il mainstream è composto da un vasto insieme di prodotti, con finalità dichiaratamente commerciali, che occupano una posizione dominante sia in campo economico, sia nella sfera dell’immaginario collettivo (i film hollywoodiani ne sono l’esempio più emblematico). La controcultura comprende una serie di tendenze underground, di rappresentazioni subculturali, di forme di espressione meno vincolate alla ricerca del successo di mercato. La produzione mainstream, seppur articolandosi in vari generi, si rivolge a un pubblico generico, per raggiungere il numero più ampio possibile di potenziali consumatori. Le correnti controculturali nascono invece da e per segmenti sociali circoscritti, e anche quando superano gli originari steccati sociogeografici, rimangono comunque connotate dalla loro matrice, per esempio di tipo razziale o generazionale. Le narrazioni mainstream propongono messaggi moralizzanti, ideali e valori sostanzialmente conservatori, ma soprattutto rispondono all’imperativo dell’happy ending. Le contronarrazioni delineano visioni anticonformiste e di solito non prevedono lieto fine.
Va detto che questa dicotomia tra mainstream e controcultura rischia qua e là di risultare troppo schematica. Tuttavia, l’autore è attento a usarla in maniera duttile, sottolineando le interferenze tra i due campi, e in modo funzionale all’esposizione della sua tesi di fondo, che in breve è la seguente: la cultura di massa americana ha conosciuto nel corso del Novecento un’evoluzione, scandita da due fasi, con un mutamento del rapporto tra produzione mainstream ed esperienze controculturali. Mentre nella prima fase, dagli anni Venti fino agli anni Cinquanta, l’egemonia della cultura di massa mainstream non venne minimamente scalfita dalle tendenze underground che pur circolavano all’interno di specifiche nicchie di pubblico (musiche come il jazz, il blues, l’hillbilly, il folk; produzioni cinematografiche indipendenti come i race movies afroamericani; mode giovanili come quella dei pachucos californiani), nella seconda, che ebbe il suo epicentro cronologico negli anni Sessanta, si affermò una «costellazione controculturale di massa» in grado di attraversare i confini sociali, razziali, territoriali, in parte anche generazionali, tanto da esercitare nei decenni successivi una certa influenza sulle narrazioni mainstream. Preceduta da importanti spazi subculturali «borderline» (su tutti, il circuito letterario della beat generation), che divennero repertori stilistici dai quali attingere, questa costellazione ha avuto la sua massima espressione nella musica rock - appunto -, ma si differenziò dalle esperienze del passato per la capacità di acquisire una dimensione intermediale, di dilatarsi all’intero sistema delle comunicazioni di massa.
Sviluppando tale asse interpretativo sulla base di innumerevoli esempi, l’autore traccia un quadro storico molto sfaccettato della cultura di massa americana, con il merito di tenerla sempre ancorata a un tessuto sociale altrettanto articolato. Affiorano così, lungo l’analisi, molteplici snodi tematici, e naturalmente non tutti risultano affrontati in modo totalmente persuasivo. Per esempio, si può discutere sulla marginalità, forse eccessiva, attribuita alla produzione culturale europea, che rimane schiacciata su un ruolo del tutto passivo fino al fenomeno della British invasion dei primi anni Sessanta. Oppure si può esprimere qualche perplessità sull’apparente compattezza delle narrazioni mainstream. Ciò non toglie però che si tratti di un libro brillante, stimolante, ricco di dati e di spunti, e - perché no? - anche molto divertente (almeno per il lettore che ha una certa familiarità con il panorama culturale esaminato). Divertente, beninteso, non nell’accezione negativa che Horkheimer e Adorno danno al termine, cioè come mera via di fuga dalla realtà e dalle responsabilità, poiché è un lavoro che non evita di affrontare aspetti problematici, connaturati alla cultura di massa americana, come il razzismo, gli stereotipi sociali, le gerarchie di genere, il materialismo e l’edonismo.

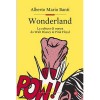

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License 2004- 2025
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License 2004- 2025
